Nautica Italiana: l’epopea storica
di Antonio Soccol
La data di riferimento mentale è quella del primo Salone Nautico di Genova: è da quel 27 gennaio del 1962 che gli addetti ai lavori fanno iniziare idealmente la comunque breve storia dello sviluppo dello yachting nazionale. Ma, volendo esser corretti, tutto era iniziato prima: Baglietto costruiva scafi da diporto già da un secolo e i motoscafi di Carlo Riva erano già famosi in Costa Azzurra fin dalla metà degli anni Cinquanta.
Poche, elitarie e praticamente tutte su ordinazione, le barche costruite a Varazze, molte (intendo dire sull’ordine delle centinaia all’anno) e già rigorosamente di serie quelle fabbricate a Sarnico.
Baglietto non era il solo a realizzare scafi one off: c’erano Celli, Craglietto, Sangermani, Carlini. E, prima della guerra, a Venezia i cantieri Soccol avevano costruito per clienti nordamericani (la leggendaria “milionaria” dell’epoca Barbara Hutton), turchi e svizzeri e, nel 1937, avevano già montato i primi motori diesel su imbarcazioni da appena 7 metri, anticipando così uno sviluppo avvenuto poi, cinquanta anni più tardi.
Non è nemmeno vero che è stato a Genova, alla prima edizione del Nautico, che si son presentate come folgoranti novità le barche in vetroresina: nella seconda metà degli anni Cinquanta le producevano già la Pozzi, la Celli-Pirelli, l’Alpa e la Cigala & Bertinetti, tanto per citare alcuni dei marchi più importanti allora sul territorio nazionale. E gli stampi per la vetroresina di **Parasiliti(vedi nota a fine articolo) avevano già fatto il giro di mezza Italia. Nelle barche a vela da diporto l’Italia aveva poca storia. In quelle a motore, però, nessuno al mondo l’aveva. Quindi la vera sfida era in questo settore: là dove tutto era nuovo per tutti, a Viareggio come a Miami Beach. Se gli americani avevano Chris Craft noi avevamo Riva.
Se loro avevano Rybovich noi avevamo Baglietto. Se gli yankee avevano i guardiacoste noi avevamo (avuto) i Mas. La Francia non esisteva, la Germania aveva altro cui pensare. La Gran Bretagna andava a vela come tutto il Grande Nord. L’Italia aveva tutte le carte per diventare padrona del mercato mondiale. Ne aveva le qualità e le capacità.
I modelli lucenti dei Cantieri Riva facevano scuola a Timossi, Piantoni, Sebino, Abbate (il padre di Tullio & C.) e a Posillipo. “Le carene dei Posillipo sono più marine perché costruite a Napoli, quelle di Riva sono più da lago.”, si diceva allora con beata ingenuità. Come se una carena che si presenta con zero gradi di diedro allo specchio di poppa possa esser meno dura su mare formato di una analoga solo perché costruita sulla costa campana invece che sul lago d’Iseo. Ma le carene a V profonda non erano ancora note e tutto era autorizzato.
La vera novità sconvolgente e determinante di quel primo Salone Nautico di Genova, in realtà, fu ‘“A Speranziella”
progettata da Renato “Sonny” Levi e costruita dalla Navaltecnica di Anzio. E’ con questa barca che inizia veramente l’evoluzione del diporto motonautico nazionale.
(Non sto dimenticando l’X 1 dei Cantieri Italcraft di Bracciano che pure, nello stesso anno, presentava una carena a “dislocamento planante” come, con infelice neologismo, dichiaravano i costruttori stessi: semplicemente di questo day- cruiser le origini progettuali sono piuttosto nebulose mentre, invece, sulla nascita e l’evoluzione della serie di imbarcazioni prodotte ad Anzio sappiamo tutto. Inoltre, e non è dettaglio trascurabile, di “Speranzelle” felicemente campa ancora oggi quasi la metà della nostra flotta di CP, Guardia di Finanza eccetera). ‘”A Speranziella”, dunque. E poi “Super Speranza” e “Settimo Velo”.
Un’ottima carena a V profonda, buona abitabilità per il saggio taglio degli interni, costruzione in lamellare senza ordinate, miglior rapporto peso-robustezza, semplicità nella costruzione in serie, facilità di manutenzione, eleganza e “sapore di mare” con quel bei teak a vista in coperta e sul pozzetto. (Cosa si può pretendere di più da un progetto di un cabinato a motore? Poco o niente ma molti ancor oggi non l’hanno capito.)
Scrivo queste note a bordo; sono ormeggiato, in qualche modo, in un porto della Calabria e inesorabilmente il mio sguardo gira fra gli scafi in banchina: a dritta un glorioso “Bora3” dei CRDA di Monfalcone, dovuto alla matita di Chiggiato (padre), il primo cabinato italiano in vetroresina: “Ha 28 anni- mi ha appena dichiarato il suo armatore che lo usa tutti i giorni dell’anno per la sua attività di pescatore subacqueo professionista – E non intendo cambiarlo con nessuno di queste barche che si fanno oggi.”, ha subito aggiunto. Certo non erano barche usa&getta, quelle dei CRDA. Ma ancor più deciso è stato l’ufficiale responsabile di una CP- SuperSperanza: “Noi, con questa barca di 30 anni fa, andiamo tranquillamente a salvare quelli che, con mare formato, si cacciano nei guai con le barche di oggi. Guardi, il progresso… lasciamo perdere.”
La sua affermazione coincide con quella dei “ragazzi” della Guardia di Finanza che, un paio di giorni fa, al largo, mi hanno controllato i documenti : “Bella barca”, mi dicono. E io di rimando: “E la vostra come va? Che motori ha?” Il comandante mi guarda cupo: “Tranne i motori, in questa barca non funziona niente… dalla carena all’ultima delle bitte.” Per amor di Patria evitiamo di citare il fornitore: Tangentopoli ha insegnato molto anche in questo campo.
Tutto derivava in quegli anni da un unico elemento: l’entusiasmo. Allora c’era e produceva errori ma anche molto fermento, molta vivacità, molta determinazione. Molta ricerca. Oggi tutto è pseudo-industrializzato, appiattito. Si è passati dal uso del verbo “inventare” a quello dell’imperativo “copia”, nella migliore delle ipotesi “migliora”. Ecco perche c’è, fra gli utenti professionisti, chi oggi vuol ignorare il sedicente progresso.
E’ molto strano per certi aspetti quello che è capitato in questa nostra nautica italiana: c’erano le idee e si voleva fare l’industria. C’erano anche i capitali (come dubitare delle possibilità di investimento di colossi quali Pirelli, Pozzi, CRDA eccetera?) e c’era stata una grandissima lezione da seguire. Parlo di Carlo Riva. Negli anni Sessanta il cantiere di Sarnico aveva già dimostrato quelle che dovevano essere le linee fondamentali: qualità, qualità e qualità. E poi, tanta, tantissima assistenza. Sul lago d’Iseo sono arrivati a produrre un motoscafo al giorno, talvolta anche di più. E, in cantiere per terra, ci potevi pure mangiare da tanto che era pulito e lindo. Gli operai in tuta, i tecnici in camice. Ogni barca collaudata da un team specializzato, tredici mani di coppale su quel compensato di mogano prestampato da Marine Plywood: una barca in 5 pezzi (specchio di poppa, due fiancate e due fondi) da 7, 8, 9 e oltre metri di lunghezza.
Nel 1964, un giorno, Carlo Riva ebbe un dubbio: una prova indicava che, forse, un suo fornitore gli aveva dato una partita di serbatoi di benzina con un difetto. Non grave, non c’era pericolo, ma il difetto c’era. Purtroppo la magagna era apparsa quando già tutta la partita era stata montata e le barche vendute e consegnate. L’ing. Carlo non ci pensò nemmeno un secondo: diede ordine di rintracciare tutti gli esemplari forse difettosi e, a proprie spese, di cambiarne il serbatoio. Non gli fu difficile farlo: tutte le barche Riva facevano riferimento o svernavano nei Riva Boat Service sparsi in Costa Azzurra, in Liguria, in Versilia e sui laghi. Così gli riuscì di fare tutta l’operazione senza nemmeno avvisare gli armatori ed evitò inutili tensioni e pettegolezzi in un ambiente che tenero non è mai stato con nessuno, tanto meno con i miti. Basta pensare al velenoso nomignolo “cric-crac” affibbiato alla Chris Craft, allora il più grande cantiere di nautica da diporto del mondo.
I Riva Boat Service erano l’altra grande intuizione industriale di quegli anni: un centro di assistenza specializzato, dove eri sicuro di trovare tutto, ma proprio tutto, quello che poteva servire alla tua barca, naturalmente purché fosse un Riva: dai ricambi dei motori alle eliche, dagli operai capaci di lavorare il legno ai verniciatori sublimi: tutta gente che già allora era obbligata a seguire stage di preparazione e di aggiornamento a Sarnico presso la “casa madre” e che insomma garantiva la stessa qualità di lavoro del costruttore. C’era persino un Riva Boat Service confinante con il cantiere stesso e a molti sembrava un paradosso perché, da sempre, il cantiere costruttore di uno scafo era considerato l’unico in grado di fargli una buona manutenzione.
L’idea di Riva era, invece, la grande affermazione dell’ordine e della logica industriale: alla Fiat chi produce automobili mica ne cura anche l’assistenza. E solo la specializzazione può assicurare la qualità (oltre che la rapidità) del lavoro. In quegli anni Sessanta la nautica esplose, ma non si affermò come fenomeno industriale. I cantieri si moltiplicavano a ritmo impossibile: un capocantiere trovava un finanziatore e subito lasciava il suo posto per aprire una nuova ditta. Talvolta era il mastro d’ascia del cantiere, altre volte il collaudatore. Un paio di volte fu il contabile. Da questa devastante polverizzazione non è ancor oggi nata l’industria.
Quando un giornalista scrive un articolo, per consuetudine, lascia che sia la redazione che glielo ha richiesto a farne il titolo: è una usanza che nasce da esigenze tecniche tipografiche. Dal 1958 a oggi calcolo di aver scritto più di tremila articoli di carattere nautico per oltre 100 diverse testate (quotidiani, settimanali, mensili, trimestrali italiani e stranieri). Una sola volta ho preteso di imporre il titolo: era per un articolo richiestomi da una pubblicazione redatta dalla Fiera di Genova. Volevano il punto sullo stato dell’arte dopo il Salone del ’70. Parafrasando il motto del maggio francese “politique d’abord”, chiesi che il pezzo si intitolasse “Nouveautés d’abord”. L’aneddoto può sembrare banale ma sintetizza, credo, l’atmosfera di quel tempo. Che poi le novità fossero davvero tali è da dimostrare. Però ci si provava davvero. C’erano polemiche tecniche sulla validità delle carene a V profonda: alcuni sostenevano la miglior qualità di quelle di Renato “Sonny” Levi e altri quelle dell’americano Ray Hunt.
Un artigiano del Sud decise che i pattini longitudinali dovevano essere deportanti e tentò di lanciare questa sua opera viva contro logica. La scienza si mescolava con l’improvvisazione, la ricerca con il tentativismo. “Le carene a V profonda funzionano solo entro una certa gamma di dimensioni: fra i 7 e gli 11 metri al massimo. Per gli scafi minori e per i motoryacht non vanno bene perché assorbono troppa potenza”, si sentiva dire da “esperti” di ogni tipo. Ma poi, molto lentamente, uno alla volta, quasi tutti i costruttori si convinsero; anche se grottescamente ancor oggi qualcuno mormora dubbi, brontola sugli effetti dei pattini e arriva a produrre obbrobri tecnicamente immorali.
Le gare offshore svolsero una loro funzione storica determinante: spinte dal mensile “Nautica” che sponsorizzava la Viareggio-Bastia-Viareggio, crearono rivalità fra cantieri ma soprattutto stimolarono progettisti e costruttori a dare il meglio.
E le nostre barche vinsero persino in Gran Bretagna, a Cowes, la culla dello yachting mondiale, mettendosi di poppa la crema del mondo, nordamericani compresi e rappresentati da gente con nomi altisonanti come Sam Griffith, Dick Bertram, Jim Wynne eccetera: una botta di prestigio mica da poco per la nascente nautica italiana. Furono gli anni in cui si scoprì la fondamentale importanza dei flaps in una barca planante: non senza che sorgessero subito i soliti bastian contrari, naturalmente. Quegli stessi che ancor oggi sostengono che, se una barca ha i flaps, vuol dire che la sua carena ha qualche difetto da “medicare”: il che, grossomodo, corrisponde a dire che se una automobile ha il cambio e i freni significa che non è stata progettata bene. La lotta fra Intelligenza e Ignoranza è atavica; non poteva mancare nella nautica. In compenso oggi tutti montano i flaps. E fanno bene perché il mare non è una autostrada tutta dritta e tutta in pianura.
Venne poi l’altra grande novità: la pesca alla grande traina, il big game fishing, predicata dalla rivista “Mondo sommerso” con l’impegno dell’allora suo editore Ferdinando Schiavoni e del suo grande giornalista di mare Antonio Cesareo. Marlin e pesci vela in Mediterraneo non ce ne sono, ma ci si può divertire lo stesso con le alalunghe, con i tonni, con le verdesche e magari con qualche altro squalo di grossa taglia. La rivista pompa la moda, Schiavoni passa ore su ore in porto a Santa Margherita Ligure a spiegare ai primi afficionados l’arte delle esche, della lunghezza delle lenze, della velocità della barca durante il traino, l’importanza dei divergenti. Si fa di tutto per enfatizzare l’argomento: un grande concorso per premiare i cantieri che realizzano le imbarcazioni più idonee stimola per la prima volta con elementi di marketing puro un mercato che non conosce minimamente i valori di questa parola, un settore dove la parola “pubblicità” è spesso confusa con “carità per quei poveracci delle riviste specializzate”, una attività produttiva dove i numeri sono così bassi che ancor oggi l’Italcraft trova giustamente meritevole ricordare di aver prodotto ben 700 esemplari del suo day cruiser “Sarima”.
La faccenda della pesca e degli sport fisherman contribuì non poco a risollevare l’andamento delle vendite appesantito dalla crisi economica che allora si chiamava “sfavorevole congiuntura”. “Mondo sommerso” pur di spingere talvolta inventava: storica una copertina con un mare molto agitato dove un redattore camuffato da uno sgargiante “nordovest” giallo ferrava un tonno gigante meraviglioso e lucente. Peccato che l’animale fosse imbalsamato e che gli sforzi del “pescatore” fossero in realtà per tenerlo un po’ sotto l’acqua piuttosto che per tirarlo a bordo. Ma nessuno dubitava, allora, di quella bibbia e i cantieri ne traevano vantaggi.
Spertini a Santa Margherita Ligure sfrutta i suggerimenti tecnici di Ferdinando Schiavoni, la bravura di Balestrino e la matita magica di Franco Harrauer e presenta l'”Alalunga 14″: una macchina da pesca perfetta, elegantissima e funzionale, da far invidia ai cantieri americani maestri in materia. Lo stesso Franco Harrauer disegna poi per la SAI Ambrosini il “Perseu”, uno sportfisherman medio in lega leggera e così anche questo materiale di costruzione si aggrega alla disponibilità ormai vastissima del mercato che vanta scafi in legno massello, in compensato marino, in lamellare marino, in vetroresina e in lega leggera. Mancano all’appello solo il ferrocemento che apparirà poco dopo per stimolo della rivista “Forza 7” e l’ABS, la grande speranza (sembrava il sistema per realizzare tantissime barche a basso prezzo) trasformatasi poi in grande delusione, che verrà lavorato dall’azienda pilota “Nautica Rio” di Sarnico.
A questo punto la storia si spezza in tre tronconi distinti: c’è chi insiste nella ricerca tecnica vera e propria, chi si affida al design e chi più “furbamente” (ah, quanto siamo “furbi”, noi italiani!) copia. C’è ancora molto da fare per avere carene morbide ad alta velocità su mare formato e l’uomo di punta in questo settore è Renato “Sonny” Levi che deve molta della sua fama alle vittorie delle varie “Speranzielle” ma che non si adagia sul passato: inventa la linea Delta, sfrutta le commesse di importanti clienti come Gianni Agnelli, Mario Agusta, Adriano Olivetti, Aga Khan eccetera per diffonderla assieme al concetto del “fast commuter”, cioè della barca velocissima e comoda per trasferimenti rapidi da un punto ad un altro della costa.
Il “G.50“, il “Barbarina“, l'”Hidalgo” e il “Corsara” (tutti costruiti dai cantieri Delta di Fiumicino) sono scafi da oltre 35 nodi con il top per i primi due che superavano i 50 nodi.
Levi si occupa anche di sportfisherman e progetta per un cliente di Città del Capo (Sud Africa) “Aquarius”, un 56′ da sogno (sempre costruito da Delta) con il quale dimostra che anche nella pesca alla traina si possono utilizzare le carene a V profonda e il collaudo viene fatto in acque al disopra di ogni sospetto: 50 miglia al largo di Capo di Buona Speranza. Ma il contributo più innovativo Levi lo offre in occasione della progettazione di “Drago” per i cantieri Italcraft.
da sogno (sempre costruito da Delta) con il quale dimostra che anche nella pesca alla traina si possono utilizzare le carene a V profonda e il collaudo viene fatto in acque al disopra di ogni sospetto: 50 miglia al largo di Capo di Buona Speranza. Ma il contributo più innovativo Levi lo offre in occasione della progettazione di “Drago” per i cantieri Italcraft.
Doveva fare 50 nodi sotto la spinta di un paio di diesel Cummins da 370 cavallicadauno. Mi ero preso questo impegno ed ero disposto a inventare l’aeroplano pur di riuscirci”, ricorda il progettista. E, in effetti, fra i disegni preliminari risulta lo studio di una scocca con ali laterali e ripieghevoli lungo la fiancata per gli ormeggi nei nostri superaffollati porticcioli. Ma non c’è stato bisogno di mettere le ali al veloce cabinato da 13 metri: sono state sufficienti le eliche di superficie per fargli raggiungere la fatidica velocità promessa dal progettista.
Le eliche di superficie: con la carena a V profonda, la più straordinaria invenzione nella nautica da diporto. Grande (sull’ordine del 20 per cento) risparmio di carburante o, a scelta, maggior velocità (sempre sullo stesso ordine di valori), diminuzione del 70 per cento dell’immersione massima in assetto di planata (un cabinato da 12 metri pesca come un fuoribordo), totale eliminazione dei gas di scarico dallo specchio di poppa (e, anche con vento in poppa, pure dal pozzetto o prendisole, che sia). Da oltre 20 anni, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ci sono barche “storiche” con eliche di superficie , ma la nautica da diporto ne diffida ancora!
“Bisogna saperle portare e i miei clienti sono così poco abili”, dicono i costruttori sostenendo così la disarmante e assolutamente controproducente teoria che per andar per mare non occorre conoscerlo e che le barche è meglio che restino sempre in porto con il classico mazzo di gladioli ben esposto a poppa. Sarà forse perché ho avuto l’occasione d’essere uno tra i primi al mondo a condurre, anche in competizioni offshore, barche con eliche di superficie, ma non ho mai capito in che cosa consista questa famosa difficoltà nell’utilizzarle: e ben più difficile – in campo automobilistico, per esempio – passare dal tradizionale cambio a 5 marce a quello automatico. Ma tant’e.
“Exocetus volans“, il nome scientifico latino del pesce volante è stato scelto per identificare- il progetto più avveniristico che la nautica italiana abbia fatto nella sua fase storica, quello del primo (e, sinora, unico al mondo) motorsailer planante. Uno scafo da 12 metri capace di filare oltre 30 nodi grazie alle eliche di superficie spinte da due diesel Aifo da 240 cavalli ciascuno e di rimontare 30 gradi di vento a vela. Una scommessa impossibile che la lag Nautica di Venezia di Nani Sartorio ha voluto affrontare con Renato “Sonny” Levi (progetto tecnico), Franco Harrauer (design) e Alex Carezzo (armamento velico), una scommessa vinta. Inutilmente, però.
Il mercato – troppo inesperto – non ha recepito la novità e così l’unico esemplare costruito in lamellare è oggi nelle mie mani e, a quasi vent’anni di distanza, suscita grande ammirazione e totale incredulità “Ma funziona?”, mi si chiede. Sì, funziona benissimo. “Ma che velocità fa?”, insistono. “Con i nuovi motori Man da 270 cavalli che è stato giocoforza montare (i CP3SM dell’Aifo sono fuori commercio da anni e non si trovano più i ricambi) la velocità massima, a barca leggera, è stata di 37,7 nodi”, rispondo.
Rimangono ammutoliti. Poi, appena esco, dal porto mi controllano. Mi stimolano a sfide che, dopo dieci anni di gare offshore, mi fanno ridere e che non accetto. Ma, quando mi metto in rotta, mi inseguono. E non mi raggiungono. Mai.
Dalla tecnica pura al design. Qui i nomi impegnati sono più numerosi, ma su tutti uno ha il merito di aver “messo in moto la trottola”: Paolo Caliari. E, idealmente, tutto nasce con il “Baglietto 16,50” che Paolo ha realizzato assieme a Pietro Baglietto.
Questo “impossibile” connubio tra il più classico dei progettisti d’allora, filo inglese per convinzione e studio, e il giovane architetto capace di disegnare profili (e interni) di grande purezza è stata la miccia che ha aperto il varco ad una produzione nazionale in assoluto la più bella del mondo. Ne ha guadagnato anche la parte tecnica perché le linee delle opere morte di Caliari hanno ottimo profilo aerodinamico: con i suoi progetti sono sparite le “casette” galleggianti, vere e proprie dighe al vento, e le barche del naviglio maggiore (oltre i 14 metri ft) hanno riacquistato diritto a questo nome.
Sarò partigiano ma nessuno dei moltissimi imitatori e “seguaci” di Caliari ha raggiunto la sua pulizia e raffinatezza: le sue barche, se hai l’occhio, le distingui proprio per questo: semplicemente non ci sono punti disarmonici. Provate a trovare un attacco “tirato” sul Tecnomarine C 42 o sul Tiger, se ci riuscite.
Seguendo altre strade mentali, direi dimostrando altro tipo di cultura, l’unico nautical designer che può vantare altrettanta pulizia di architettura è Pierluigi Spadolini.
I vari “Polaris” e “Pegasus” dei Cantieri di Pisa erano ottime barche, costruite in modo assolutamente perfetto, ma la gamma di questo grande produttore versiliese è migliorata in modo determinante con l’arrivo del superbo modello “Akir”, firmato appunto da Spadolini.
L’epopea della nautica a motore italiana brilla di luce assoluta negli anni Settanta: il Salone di Genova è l’appuntamento dove i più attenti e intelligenti costruttori del mondo vengono a vedere le novità e le tendenze. Quei nomi mitici d’oltreoceano e d’oltreManica non perdono una occasione per studiarci e imitarci. Ma, purtroppo, nello stesso tempo, grottescamente, la maggior parte dei nostri cantieri, quella grande massa creata dal polverone dell’entusiasmo, si sfianca a copiare per la millesima volta il “Bahia” di Bertram, i Boston Whaler della Fisher eccetera, a produrre scafi in vetroresina imitando il fasciame clincker, chiamando “pilotine” delle tinozze ignobili che nemmeno “NonnaPapera”, mortificando tecnica e design, chiedendo progetti di barche a motore a designer svedesi esperti di vela…
Tutti alla ricerca dei famosi “grandi numeri” seguendo le misere strade del risparmio e inseguendo miti che, in realtà, venivano da noi a scuola. E preparando così il terreno culturale più fertile per quella catastrofica invasione che abbiamo subito negli anni Ottanta e dalla quale stentiamo a liberarci nonostante gli sbalzi del dollaro e la svalutazione della lira.
Il fatto è questo: per fare l’industria ci vogliono anche gli industriali. La nautica italiana, sinora, non ne ha avuti. E perciò ha perso la sua sfida per la conquista dei mercati mondiali nel settore motonautico.
Testo pubblicato da “Architettura del Mare – La progettazione nella nautica da diporto in Italia”, a cura di Massimo Canfailla, Antony Lee, Eugenio Martera, Pierpaolo Perra. Comitato scientifico: Paolo Caliari, Pierluigi Spadolini, Andrea Vallicelli e Vittorio Garroni Carbonara (Facoltà di Architettura di Genova), Vincenzo Majone (Facoltà di Architettura di Napoli), Fausto Pugnaloni (Facoltà di Architettura di Ancona), Roberto Segoni (Facoltà di Architettura di Firenze), Alberto Esposito (Facoltà di Architettura di Palermo), Rosario Vernuccio (Facoltà di Architettura di Firenze), Gianni Zuccon (Facoltà di Architettura di Roma). Pubblicazione ideata e promossa da “Contemporanea- Centro ricerca e Promozione Ambienti Urbani”. Alinea editrice srl- Firenze – 254 pagine- 1994.
Questo testo viene qui riportato per g.c. dell’autore. – Tutti i diritti riservati. Note Legali
Le immagini pubblicate in questo articolo sono in parte tratte dal testo “Architettura del Mare”, dal n° 30 – 31 / 1964 di “Nautica” ed in parte dai nostri archivi.
** Su richiesta della signora Ada Parasiliti, sorella dell’ing. Jano Parasiliti aggiungiamo le seguenti notizie:
Jano Parasiliti: un pioniere nella epopea della motonautica italiana di “plastica rinforzata”
Sebastiano Parasiliti, si è laureato a Napoli nel 1951 con il prof. Felice Ippolito che non seguirà poi a Roma nel campo nucleare, perché la sua grande passione per il mare e per le barche, coltivata fin da bambino, lo stimolavano a differenti obiettivi.
Nel fertile terreno dell’impresa di famiglia, avviata da mio padre nel settore cantieristico a Napoli, quasi subito inizia la lavorazione della plastica rinforzata. Sono anni di creatività forte in cui Jano avvia in Italia l’evoluzione delle barche, che fino ad allora si costruivano solo in legno, acquistando materiale dalla Montecatini e dalla Balzaretti & Modigliani.
Già nel periodo 1954/55 il Cantiere Parasiliti potè così varare il primo prototipo di natante in materiale plastico. Conserviamo ancora in famiglia testimonianza delle pagine pubblicitarie all’epoca apparse su “Spruzzi & Virate” e su “Vela e Motore”. Conserviamo anche le fotografie delle altre barche costruite in seguito: la Conchita (la mia personale barchetta a remi che ha accompagnato gioiose gite a mare con gli amici fino al 1959), la Procellaria, chiamata così perché ogni volta che dovevano fare la prova di galleggiamento in vasca arrivava il cattivo tempo.
Ed ancora, foto del cabinato che nel 1958, durante un congresso della Saint Gobain in Francia, è stato considerato il più innovativo natante costruito in Europa.
Il nostro pioneristico cantiere è stato poi ceduto alla FIART nel 1960. Successivamente il management di questa azienda ha avuto il merito di espanderne l’attività e di conquistare posizioni di eccellenza mondiale.
Il tempo e la tecnologia evolvono, ma restano in me ancora vive le esperienze sperimentali e di innovazione produttiva che mio fratello, mancato ormai diversi anni fa, aveva avviato con non comune lungimiranza. Tuttora, rimane viva l’emozione di aver vissuto quel periodo di straordinarie scoperte e di aver potuto condividere con molti
amici cari il privilegio di aver avuto a disposizione tutti i prototipi che via via venivano messi a mare. Tra questi ricordo anche un avveniristico piccolo aliscafo da diporto, che nessuno di noi giovani di allora ebbe il coraggio di sperimentare.
Ceduto ad altri il Cantiere Parasiliti, concreto esempio della Napoli industriosa e creativa, Jano, dopo una ultima barca a vela progettata per il suo personale diletto, cessò di occuparsi di questo campo di attività e si dedicò ad altre sperimentazioni nel settore dei macchinari per industrie di rilevanti dimensioni. Senza tuttavia rinunciare alla inventiva anche in famiglia, assecondando la mia passione in cucina e a conferma del suo originale libero ingegno, mi realizzò piccoli antenati dei robot, che oggi sono, grazie ad altri, strumenti di lavoro tra i fornelli di ogni misura, anche in viaggio per mare.

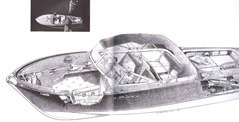





































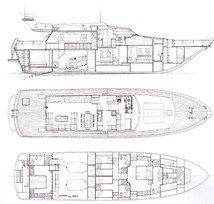






















Il signor Vito conferma la situazione e non ho nulla da obiettare.
A prescindere dai balzelli che frenano il diportista, la crisi delle PMI è ammirevolmente descritta nel libro di E.Nesi “Storia della mia gente” (Bompiani) in cui racconta la battaglia persa a Prato contro i cinesi. Mutatis mutandis è la fine che faranno le PMI del settore nautico se non si consorzieranno. La mania del “piccolo è bello” (provocata a suo tempo anche a causa dei sindacati) è tramontata e chi non si adegua fallirà.
Tentare di regolamentare la globalizzazione è combattere contro il caos. La globalizzazione è figlia dei media, TV Internet ecc, e non la ferma più nessuno.
Vittorio di Sambuy
Salve a tutti.
Signor Compagnucci, concordo molto quando asserisce che l’Italia, nonostante sia un paese circondato dal mare, non ha assolutamente una cultura nautica, mentre lo sono molto meno sul fatto che la “Finanza”,in un certo qual modo, abbia contribuito a ciò considerando più o meno tutti degli evasori.
Personalmente conosco quanto può costare una barca a vela poco blasonata, con magari cinque lustri sulle spalle, ma la differenza dei costi di gestione è minima tra una nuova che costi 400/500 mila euro, specialmente l’ormeggio che se poco poco sei nel posto sbagliato è bello salato.
Questi sono alcuni dei parametri di valutazione circa le reali possibilità economiche, poi è inutile girarci intorno, oltretutto sono anche io un diportista e non nego che la barca grande o piccola che sia non è un bene di primaria necessità, quindi complice anche chi la sfoggia come un fallico simbolo, l’opinione comune sarà sempre quella di misurare la “potenza economica” dalla barca che uno si permette, nonostante abbia conosciuto personaggi che veramente potevano permettersi signore barche, ma che si accontentavano di tirare due bordi su una deriva o un giretto sul gommone con comando a barra!
Grazie, saluti,
Vito
Caro Soccol, condivido tutto di quello che dice e scrive, tuttavia ci terrei a fare due considerazioni che vanno inserite nel quadro che lei ha molto ben illustrato:
La prima è che l’italia, nonostante sia un paese circondato dal mare non ha assolutamente una cultura nutica, anzi, ogni volta che l’argomento viene trattato dai media, si fa vedere il solito megayacht, col risultato che si rafforza sempre di più il connubio Nautica/milionari.
Di conseguenza, se uno ha una barca e non dichiara almeno un milione di Euro, è un evasore.
Il fatto che poi uno sia proprietario di un 10 mt di dieci anni di età, non importa, per la finanza uno se ha una barca è un evasore.
Questa cosa ha tenuto lontani molti dal mare…
La seconda considerazione che deve essere fatta, è che quelli che lei chiama imprenditori, fanno bene i conti prima di investire in attività che per i motivi di cui sopra, sarebbero implicitamente illecite, in quanto i probabili clienti di suddette attività sarebbero mafiosi, evesori, e quant’altro.
inevitabilmente chi si macchiasse della colpa di costruire barche, secondo la mentalità di molti ancora oggi, sarebbero rei almeno di concussione.
Salvo poi creare il leasing nautico, con proclami e grandi annunci, invitando esplicitamente a farne uso….
Salvo poi oggi, rimettere tutto in discussione ventilando l’ipotesi di dover provare l’uso del mezzo leasingato all’estero, esibendo ricevute e scontrini…
Caro Soccol, io sono convinto che con la congiuntura che c’è stata ed in parte ancora c’è in Italia, quello che la nautica ha fatto, creato, inventato sia un vero miracolo italiano, dovuto ad alcuni appassionti che si sono improvvisati imprenditori, a volte con successo, a volte meno….
Con stima,
Massimo Compagnucci.