Solitario di Alberto Cavanna
Una volta che un tizio, con fare scherzoso, lo aveva apostrofato reietto delle isole’, lui aveva fatto una scenata in banchina che la gente si era fermata.
“Guardi che dove giro io di isole non ce n’è: solo mare!
Non sono mica un marinaio della domenica come lei – urlava con l’indice alzato sotto al naso del ragazzo abbronzato – e poi si ricordi che Conrad io non l’ho letto: l’ho conosciuto, caro il mio giovanotto!”
Era una delle sue solite sparate.
Il fatto era che quel tizio strampalato con più anni di Noé, in giro per il Mediterraneo su di una barca talmente vecchia e scassata che persino Moitessier avrebbe avuto vergogna a salirci, era una testina con cui si sapeva fosse meglio non misurarsi, e quelli che bazzicavano usualmente nei vari porti della zona lo conoscevano bene.
Il giovane, per farla corta, si era scusato e aveva continuato la passeggiata mentre lui borbottando mugugni finiva di ormeggiarsi al molo dove era appena attraccato, reduce una crociera ininterrotta di oltre venti giorni senza scalo.
Sulle banchine che frequentava a seconda dei venti e dei meteo stagionali, era conosciuto come ‘il solitario’ e, tutto sommato a parte qualche screzio, la sua figura caratteristica, se non proprio accettata, veniva tollerata da quasi tutti.
Lo vedevano arrivare con il suo decrepito 30 piedi, una delle prime barche in fibra e talmente pesante che, anche con 40 nodi di vento, riusciva a tenere tutta la vela: l’albero era uno dei primi in alluminio e sembrava un palo della luce; il resto della barca una via di mezzo tra un peschereccio e la zattera del Méduse.
Le vele erano poi così fruste e rappezzate che si sapeva del suo arrivo non appena diventavano visibili all’orizzonte.
Arrivava periodicamente negli stessi porti; andava all’ufficio postale a ritirare la pensione; faceva cambusa, gasolio e qualche riparazione; sostava una settimana dieci giorni senza mettere piede nei bar e osterie per poi ripartire senza preavviso, così come era arrivato.
Nessuno, oltre questo, sapeva nulla di lui ed anche quei pochi che avevano provato ad indagare, complici le amicizie femminili tra le impiegate delle poste o le mogli della locale caserma dei Carabinieri, nulla erano riusciti a scoprire se non un anonimo nome e cognome, una ancor più incolore provenienza dal capoluogo lombardo e qualcosa relativamente all’età (ben bene avanzata, senza dubbio: lo si poteva tranquillamente dedurre dalla schiena curva e dalla pelle corrugata color tabacco).
La sua giornata iniziava col sorgere del sole e terminava due ore dopo il tramonto (salvo avverse condizioni meteo) e l’unico svago che gli si era visto concedersi era una pipata in pozzetto, la schiena appoggiata alla tuga e le gambe allungate sulle sedute. Un vecchio gatto gli stava in grembo e si beava delle lente carezze delle mani legnose.
Lo aveva trovato anni prima su di un molo; o meglio, era la bestiola che aveva trovato lui.
Completamente nero, guercio da un occhio e segnato da innumerevoli battaglie con gli altri felini del porto, si era seduto davanti alla poppa della barca aspettando l’elemosina di un poco di cibo.
L’uomo gli aveva messo qualche avanzo in un po’ di carta di giornale e se ne era andato in cuccetta.
La mattina dopo il gatto, non si sa come fosse riuscito a saltare a bordo, lo aspettava in coperta per la colazione.
“Argo…”, gli disse il vecchio accarezzandolo sulla schiena ossuta e ispida.
“Se ti sta bene ti imbarcherai con questo nome…Caro, buon vecchio Argo…”
E da quel momento non si erano separati, continuando per qualche anno il loro vagabondare per i porti della costa, dividendo in simbiosi assoluta il mare, il silenzio e i pochi metri di cabina e ponte.
Lui al gatto parlava spesso.
Lo salutava al mattino e facevano colazione insieme; commentava con lui i bollettini meteo, il vento e l’orientamento delle vele.
Qualche volta ci aveva anche litigato.
Ma una mattina d’autunno inoltrato, erano in mare da una settimana, il gatto non si era fatto vivo. Il vecchio lo aveva chiamato diverse volte dal pozzetto poi era sceso a cercarlo in cabina.
Lo aveva trovato accoccolato nel piccolo gavone che era diventato la sua cuccia: sembrava addormentato.
Non disse nulla e lo prese delicatamente in braccio.
Lo fasciò poi con cura in un vecchio sacco di iuta, assieme al topo di corda sfilacciata che gli aveva fatto per farlo giocare ed un vecchio ancorotto. Cucì il tutto con cura, andò al coronamento e lo lasciò scivolare da poppa.
Diede solo uno sguardo con la coda dell’occhio alla piccola macchia chiara spariva ondeggiando verso il fondo e si concentrò sulla rotta e sui lavoretti urgenti da fare.
Continuò la vita di sempre da solo, crociera dopo crociera, porto dopo porto, anno dopo anno.
E gli anni passarono uguali, lenti, silenziosi… Fino ad un giorno di fine agosto.
Il tempo era stato inclemente e le burrasche si erano succedute repentine e violente. Poi era sembrato migliorare e lui aveva ripreso il mare.
Non era distante dalla costa quando si rese conto che qualcosa non andava: brutte nuvole, basse e nere, erano sulla sua prua.
Rimase incerto se ridurre e preparasi al maltempo o tornare indietro, ma si sentiva indeciso e svogliato: non si sentiva nella sua forma migliore.
Stava lavorando sulla drizza della randa quando sentì le mani formicolare e, prima che potesse capire cosa stesse succedendo, la mazzata lo aveva preso come sulla schiena, all’altezza delle scapole.
Cadde bocconi col fiato tagliato. Per un momento tutto era diventato buio.
Si rialzò piano, ma il petto gli doleva come se gli avessero dato una martellata. Le gambe e le mani tremavano incontrollabili.
“Meglio virare… Non ce la faccio a ridurre…” pensò.
Rientrò faticosamente in pozzetto e si lasciò stramazzare vicino al timone.
Voleva cambiare mure ed invertire la rotta ma non ce la fece ad alzarsi.
Con uno sforzo inumano riuscì a voltare appena la testa, tanto da rendersi conto che la costa era lontana.
Troppo lontana.
Non ce l’avrebbe mai fatta a manovrare per raggiungerla…
Ma non serviva più, non c’era più porto che lo avrebbe messo a riparo da quella buriana… Non restava acqua per manovrare: ormai era arrivato.
Il viaggio era finito…
Con l’ultimo sforzo immane si legò la mano alla barra con la scotta, la passò intorno alla vita e diede volta alla galloccia degli ormeggi.
La radio gracchiò l’avviso di burrasca: la capitaneria di porto invitava tutte le barche in navigazione a rientrare nel porto più vicino.
“Sì…”, disse lui con un’ultima scintilla, “per finire pieno di tubi in un letto dei vostri ospedali di merda… Ma và a cagare, scemo!”
Aggiustò la rotta dritto verso il largo, proprio verso il punto più nero della tempesta, ma non riuscì a capire se erano nuvole o era la sua vista che faceva apparire tutto scuro e confuso.
Il primo lampo squarciò il velo incombente e l’uomo sentì sulla faccia il vento fresco dei piovaschi che stavano per arrivare.
“Argo eccoci. Stiamo arrivando…”, riuscì ancora a mormorare.
Poi le nuvole nere scesero.
Chiuse gli occhi, si fece il segno della croce e strinse il legno.
Un colpo sull’onda gli fece cadere la testa da un lato e rimase così, dondolando di qua e di là, seguendo i giochi della barra.
La barca si inclinò sotto la raffica violenta e proseguì nel suo viaggio verso gli scrosci di pioggia, tagliando l’onda pesante e tranquilla, come se lui fosse ancora al timone.
L’immagine pubblicata all’inizio di questo articolo è un quadro intitolato “the fighting temeraire”, realizzato dallo scittore e maestro Alberto Cavanna





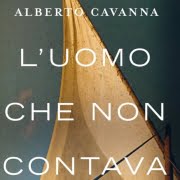


















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!