Il faro di Alberto Cavanna
Aveva già passato i quaranta quando si era trovato senza lavoro ed era tanta roba perché per lui, fino a quel omento, il lavoro era stato tutta la sua vita.
Per dirla tutta la cosa non gli era spiaciuta più di tanto: da qualche mese non era soddisfatto di come stessero andando i rapporti con la nuova proprietà dell’impresa di cui era dirigente da anni e nelle ultime due settimane aveva litigato di brutto con il nuovo amministratore delegato. Così, quando gli era stata prospettata la possibilità di un trasferimento, lui aveva prima nicchiato e poi decisamente risposto picche, sicché la sua uscita era diventata certezza a breve termine. Si trovò senza impegni, con una discreta quantità di denaro e troppo tempo libero di quanto fosse in grado di gestire.
Non aveva una famiglia su cui scaricare il problema, non aveva mai avuto un momento per poter pensare di farsene una e le sue partners abituali venivano tutte dal suo stesso ambiente, per cui, anche se ne avesse avuto voglia, gli sarebbe mancato la materia prima. Non che fosse un lupo solitario, questo no: non gli piaceva l’idea della solitudine fine a se stessa, ma aveva bisogno dei suoi spazi e la semplice idea di una convivenza lo mandava in crisi.
Fino a quel momento gli era stato di conforto il pensiero che non era ancora vecchio abbastanza per pensare a moglie, figli e casa: ancora qualche anno poteva dedicarlo ai suoi interessi e poi avrebbe visto. Il problema era che, in quel momento, i suoi interessi abituali, impegni professionali, lavoro, stress, erano venuti meno e ora sentiva, latente e pericoloso, un gran vuoto nella testa. Fu proprio in quei giorni che trovò il faro.
Aveva una bella casa in città ma da sempre aveva sentito il bisogno di un posto dove rifugiarsi nei fine settimana. Aveva dato incarico al suo agente immobiliare di trovargli un qualcosa di idoneo ma era stato talmente indefinito che il poveruomo non aveva capito se doveva trovargli un castello in Irlanda, un’isba nella steppa o una capanna su un’isola deserta. Si era dimenticato di quel capriccio quando l’uomo si rifece vivo, un pomeriggio in cui aveva iniziato a fare i conti con l’ozio.
 “E’ una cosa un poco particolare…”, gli aveva anticipato, “ma sono sicuro che potrebbe piacerle.”
“E’ una cosa un poco particolare…”, gli aveva anticipato, “ma sono sicuro che potrebbe piacerle.”
Si erano trovati sulla costa e avevano preso la via della scogliera.
“Eccoci arrivati!”, aveva detto l’agente di fronte a un faro abbandonato.
Lui lo aveva osservato un poco perplesso ma dopo qualche minuto aveva finalmente capito come avrebbe impegnato i prossimi mesi nell’attesa di un altro lavoro.
Dopo neanche una settimana aveva concluso e ne aveva preso possesso. C’era poco da stare allegri: la costruzione era disabitata da una ventina d’anni: si ergeva in un punto impervio della scogliera, la strada si fermava giusto un cinquanta metri prima e il resto era da scarpinare. Definire la sistemazione spartana era un eufemismo: al piano terra un magazzino, al primo la cucina e il bagno, al terzo un locale indefinito che avrebbe potuto essere un soggiorno, al quarto la camera da letto, proprio sotto l’area delle lanterne.
Il fanale non c’era più, era stato portato via al tempo della dismissione: restava la grande piattaforma protetta dalla vetrata e alcuni meccanismi arrugginiti ma il posto era l’ideale per realizzarci uno studio. Fuori, ai piedi della costruzione, un locale alloggiava il gruppo elettrogeno, un pezzo da museo, e la lavanderia. Lavorò come un matto per qualche mese, facendosi tutto da solo: si alzava all’alba, il tempo di un caffè e poi impastava cemento, tirava cavi, stendeva tubature.
La sera, stanchissimo, si preparava un boccone e poi si metteva su una sdraio sulla piattaforma a guardare le stelle, a sentire il mare, leggiucchiare e finire la bottiglia. Fu proprio durante una di quelle sere estive, una nottata meravigliosa di luna piena, che vide la vide: all’inizio gli era sembrata solo un’ombra, come un cespuglio mosso dalla brezza, poi si era reso conto che, sulla scogliera, stava camminando una ragazza da sola. La osservò a lungo: non trovava per nulla strano che qualcun altro, come lui d’altronde, si stesse godendo la nottata.
Ma la sera dopo, quando la rivide, più o meno alla stessa ora, rimase un poco perplesso. La sua curiosità divenne poi incontenibile quando, durante un acquazzone con tuoni e fulmini da tempesta tropicale, vide la piccola figura, camminare sulle rocce incurante della pioggia torrenziale. Uscì di corsa, magari aveva bisogno di aiuto, ma, arrivato sul posto non trovò nessuno. Quella notte il sonno tardava a venire e si trovò a pensare alla ragazza: probabilmente cercava qualcosa o qualcuno: si convinse che, probabilmente, doveva aver perso il cane o il gatto e tornava a cercarlo nei momenti di libertà.
Il giorno dopo, nell’alimentari del paese vicino, chiese se per caso qualcuno avesse perduto un animale; la signora gli domandò del perché di quella domanda e lui raccontò della ragazza. La signora rimase allibita: “Allora l’ha vista anche lei!” e raccontò che l’ultimo guardiano del faro, morto da qualche anno, raccontava di uno spettro che passeggiava di notte sugli scogli ma nessuno gli aveva mai dato retta. Lui, che a quelle cose non aveva mai creduto, si mise a ridere, ringraziò la signora, prese i sacchetti e tornò al faro.
Ma quella sera si mise ad aspettare la visitatrice che, puntuale, si presentò allo stesso punto e alla stessa ora: la osservò attentamente mentre faceva avanti e indietro sulle rocce e, con i binocoli, cercò di guardarla in viso. Non c’era molta luce ma riuscì a distinguere la figura diafana di una giovane donna, vestita con un lungo abito leggero, dal taglio antiquato. La sera dopo era tra gli scogli, nascosto, ad attenderla e, come al solito, non dovette aspettare molto.
Lei gli passò vicino: era molto bella.
“Perché vieni qui tutte le sere?”, gli disse senza tanti preamboli.
La ragazza trasalì spaventata con un piccolo urlo.
“Mi hai fatto paura!”, disse portandosi una mano sul petto.
“Veramente dovrei essere io ad averne, vista la situazione. Comunque scusa, non era mia intenzione spaventarti. Puoi rimanere quanto vuoi…
Come ti chiami?”
La ragazza rimase un attimo pensierosa.
“Sai che non me lo ricordo? Aspetta: forse mi chiamavano Elena.
Oppure Carlotta. O era Valentina… Comunque non ha più importanza: non mi serve più e poi è passato tanto tempo.
“E tu chi sei?”
Lui raccontò tutto, del lavoro, del faro e di come si fosse incuriosito vedendola passare. Stava ancora parlando quando lei lo interruppe frettolosa: “Scusami ma ora devo andare. Non posso stare qui più di un’ora…”
“Va bene… Allora torno domani, così mi spieghi cosa ci fai qui.”
La ragazza se ne andò leggera come era venuta e lui la osservò con attenzione mentre si allontanava: doveva essere stata una gran bella donna, pensò. La sera dopo si rividero. Lei iniziò il suo racconto ma fu interrotta alla solita ora e così continuò le sere dopo. Alla fine lui era riuscito a mettere insieme più o meno i pezzi del mosaico ed a costruire la strana storia della ragazza fantasma. Ai primi anni del secolo precedente lei viveva in una casa vicina. Era benestante e suo padre era molto rigido e severo. Una sera era fuggita di casa disperata e, dopo aver vagato sulla scogliera, piuttosto che tornare a casa si era gettata sugli scogli sottostanti.
“Perché?”, le aveva chiesto.
“Non me lo ricordo…”, aveva risposto lei pensierosa, “probabilmente per una stupidaggine: mi sembra di ricordare che mio padre mi avesse regalato un cavallo bianco mentre io ne volevo uno nero… O era per la carta da parati gialla che io volevo rosa. E chi lo sa più… Comunque una cosa è certa: dovevo essere una ragazzina viziata…”
E quando lui le aveva chiesto come mai tornasse tutte le sere, lei si era intristita.
“Mi hanno cercata per tanto tempo ma non mi hanno mai trovato, allora vengo qui a cercarmi…”
“E ti sei trovata?”
Lei si era alzata dalla pietra dove era seduta e lo aveva portato sul ciglio del dirupo.
“Vedi quel crepaccio a mezza costa?”
Il balzo della scogliera era molto alto, almeno un centinaio di metri in quel punto, ma, illuminato dalla luna, si vedeva, una trentina di metri più in basso, una balza uscire dalla parete rocciosa. Tra questa e la montagna una piccola fessura nera.
“Sei lì dentro?”
Lei aveva fatto segno di sì con la testa.
“E se ti trovassi?”
Lei lo aveva guardato attonita.
“Faresti questo per me? Scenderesti fin laggiù per tirarmi fuori?”
Lui aveva detto di sì.
“Allora, se avessi la tomba che mio padre cercò inutilmente di darmi fino a morirne di dolore, io sarei in pace. Ma non tornerei più…”
Lui ci era rimasto quasi male, ma poi aveva confermato che lo avrebbe fatto. Così, qualche giorno dopo, in pieno sole, era andato a fare un sopralluogo. Non era una cosa da poco: bisognava calarsi di peso perché, proprio in quel punto, la parete rientrava. Osservò lo sperone con i binocoli: la fessura non era larga più di un metro e sembrava anche molto profonda. Si procurò tutto il necessario e decise di agire la prima giornata di tempo bello; ormai era settembre inoltrato e le giornate si andavano accorciandosi. La sera prima rivide la ragazza.
“E’ per domani.”, gli disse lui.
Lei sorrise e lo sfiorò con la mano: lui sentì sul viso un soffio di aria gelata. La salutò per l’ultima volta e se ne tornò al faro: “Devo essere proprio rincoglionito…”, si disse e decise che doveva assolutamente tornare a lavorare o la sua salute mentale ne avrebbe sofferto. Il giorno dopo, di buon mattino arrivò sul ciglione. Assicurò la corda a un grosso albero, si imbragò e scese fino allo sperone. Il crepaccio era scuro ma non profondo come sembrava e riuscì a entrare senza difficoltà. Era una fenditura nella roccia piena di nidi di gabbiani, dalle pareti lisce e asciutte; il fondo era piatto e sabbioso.
Luccicava qualcosa nella sabbia: era un piccolo anello d’oro, ancora infilato in quello che rimaneva di una piccola mano. Lo sfilò con cura e se lo mise al mignolo. La ragazza era lì, almeno quel poco che ne rimaneva. La mise nello zainetto con cura, cercando di non lasciare indietro nulla: il tempo aveva fatto il suo lavoro e non dovette mettere insieme molta roba. Si arrampicò fino all’uscita e, come fu fuori, rimase abbagliato dal sole.
Nella fessura era buio e ora stentava a vedere: la luce lo abbacinava e rendeva la sua camminata incerta. Si mosse verso l’imbragatura che si era sfilato per entrare nel crepaccio ma mise un piede male.
“O Cristo!”, urlò spaventato. Scivolò di lato, cercò di afferrarsi a un cespuglio ma gli rimase in mano.
“No! No!!”, riuscì ancora a dire, poi le mani si strinsero nel vuoto. Sentì il colpo tremendo delle rocce e poi il freddo dell’acqua. Nient’altro.
Alcuni giorni dopo il postino, preoccupato di trovare la cassetta piena, avvisò i vigili. Non ci misero molto a trovare la corda e l’imbragatura. Le autorità conclusero che era morto mentre faceva alpinismo senza averne la dovuta esperienza e chiusero il caso anche se il corpo non era stato ritrovato. Il faro venne ereditato da suoi parenti lontani che lo vendettero dopo qualche anno a una coppia anziana. Ci si stabilirono alla fine della primavera, decisi a passare in quel posto i loro ultimi anni. Erano gente tranquilla, e la sera, dopo cena, salivano sulla piattaforma a godersi il rumore del mare, la brezza e le cicale.
“Non siamo soli”, disse lui una sera.
“Chi c’è?”
“Due tizi, la sulla scogliera… Passeggiano.”
“Cosa fai?”, disse lei ridacchiando, “Alla tua età ti metti a spiare le coppiette?”
“Più che altro non vorrei che ci prendessero l’abitudine…”
“Va bene… Faremo mettere un recinto con scritto ‘Vietato l’ingresso agli estranei’.”
“Forse non serve…”, disse l’uomo alzandosi per guardare meglio.
“Guarda… Se ne già sono andati.”




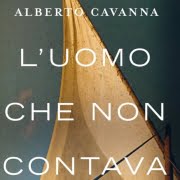


















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!