Piaggio PC 7 Pinocchio
di Franco Harrauer
Lago di Garda 1934 – Idroscalo di Desenzano
La parete rocciosa della sponda lombarda del lago ampliava e faceva eco all’interminabile urlo di cinquanta secondi dei tremila cavalli scatenati in decollo dal rosso idrovolante in corsa per il primato mondiale di velocità e per la gara di velocità della Coppa Schneider.
Centocinquanta secondi per portare in “redan” il Piaggio P7 Pinocchio, staccare i galleggianti dalla superficie del lago e accelerare verso il traguardo dei settecento chilometri orari. Centocinquanta secondi nei quali il bolide rosso percorreva quasi tre chilometri prima di riuscire a volare. Oggi siamo abituati a tempi di decollo di quindici, venti secondi, nei quali prima della “rotazione“, (il vecchio – redan) il nostro jet percorre non più di cinquecento metri. Ma tutto grazie agli efficienti e moderni sistemi aerodinamici, di ipersostentazione che trasformano l’ala al decollo ed all’atterraggio.
I velivoli relativamente veloci degli anni 20’ – 30’, avevano ali i cui profili biconvessi e simmetrici sembravano quelli di un rasoio nel cui spessore non c’era posto per artifici aerodinamici, né per carrelli retrattili. Quindi per le alte velocità di atterraggio e decollo gli aerei necessitavano di spazi sempre più estesi.
Da questa esigenza nacque l’idrovolante adatto alle infinite superfici del mare e dei laghi a disposizione.
Abbandonata la configurazione “fusoliera/galleggiante” sostenuta in aria da un sistema a due ali e da un “castello motore“, il monoplano per galleggiare doveva poggiare in acqua su due scafi molto ben profilati, ma di volume e peso sempre penalizzanti in termini di resistenza: gli “scarponi“.
Negli anni trenta questa era l’architettura di quasi tutti gli idrovolanti che erano in gara per l’ambito “Trofeo Schneider” destinato al velivolo più veloce del mondo.
L’ingegner Giovanni Pegna della Piaggio, la cui attività fu particolarmente intensa nello studio sulle “alette idroplane” oggi in uso sugli aliscafi, in seguito ad un approfondito esame dei mezzi con i quali, sino a quel momento erano stati ottenuti gli incrementi di velocità, che incidevano solo per una piccola parte sulla riduzione dei fattori negativi, (resistenza) e invece per una parte preminente sull’accrescimento dei fattori positivi (potenza propulsiva), venne alla seguente singolare determinazione che servivano in modo prevalente per neutralizzare l’influenza dei primi.
Rivolse quindi il suo studio non tanto verso l’affinamento aerodinamico degli idrovolanti, addirittura verso l’abolizione di alcuni elementi chiaramente negativi, ritenendo opportuno eliminare gli “scarponi“. Infatti, essi altro non erano che i due grandi galleggianti, dispersori della grossa porzione di potenza dei motori.
Le sue alette idroplane potevano offrire questa possibilità e teoricamente la soluzione appariva seducente e molto elegante. Da notare che essa era piena di incognite.. Nulla era mai stato realizzato in precedenza e non si potevano avere termini di paragone basati su passate esperienze.
L’adozione delle alette triplane come accorgimento di decollo, imponeva una quantità di condizioni che possiamo così riassumere:
- Fusoliera stagna in quanto doveva funzionare da scafo galleggiante

- Adozione di un’elica marina per fornire la necessaria velocità di sostentamento sulle alette, altrimenti l’elica aerea non avrebbe potuto girare e funzionare
- Adozione di due motori per i due metodi di propulsione, uno marino e l’altro aereo
- Oppure di un solo motore ma con un dispositivo di disinnesto della propulsione marina ed un innesto di quella aerea, con lunghi alberi di trasmissione, riduttori ed innesti a frizione
L’idrovolante avrebbe potuto avere dimensioni minime, come evidenziato dalla fotografia (B) ripresa in un hangar di Desenzano a confronto con gli altri velivoli da primato come il Macchi M 39 ed il Savoia Marchetti S65, con sezioni frontali resistenti ridottissime, istallando potenze minori con pesi ridotti e velocità elevatissime, pur conservando teoricamente i vantaggi dell’idrovolante per le resistenze del decollo ed atterraggio che frenavano l’aumento della velocità massima degli aerei terrestri.
Naturalmente tutti questi problemi, risolti in sede teorica, sarebbero stati risolti anche in pratica attraverso una metodica serie di prove, ma la loro complessa natura prolungò alquanto le prove e l’ingegnosa macchina non poté essere presente alla “Coppa Schneider” del 1929, pur se le prime prove di flottaggio effettuate dal collaudatore Dal Molin avevano dato esito soddisfacente, come si può vedere nella foto a fianco.
In seguito l’apparecchio fu abbandonato per le difficoltà ed il costo della sua messa a punto.
In realtà l’ing. Pegna lasciò la Piaggio per dissapori con la dirigenza e l’ing. Gabrielli, insigne progettista di aerei della Fiat che, da me intervistato molti anni dopo, mi disse di aver eseguito per conto di Pegna delle esperienze presso la “Vasca navale di Roma”, sulle alette idroplane ed aveva constatato che a certe velocità critiche si verificavano fenomeni di aspirazione di aria dalla superficie. Fenomeni che innescavano uno stallo idrodinamico con conseguente brusca caduta della portanza.
Gabrielli suggerì l’adozione di barriere del tipo successivamente posto sui piedi dei motori fuoribordo sopra le eliche. Però, a quel punto il progetto stava per essere abbandonato.
Il “Piaggio PC7” era un monoplano con ala ellittica e con fusoliera a forma di scafo portante, poiché inferiormente aveva una coppia di pinne anteriori ed una pinna posteriore, capaci di permettere il sollevamento dello scafo dall’acqua (A) una volta raggiunta una certa velocità.
Questa era assicurata dalla spinta dell’ elica marina che, emerso lo scafo dall’acqua, il moto veniva trasmesso all’elica aerea ormai libera di girare, dando luogo al decollo.
Il motore era un Isotta Fraschini a V da 800 HP ed era sistemato in fusoliera subito davanti all’ala ed il raffreddamento del liquido refrigerante avveniva mediante superfici radianti poste sul dorso dell’ala, mentre i radiatori dell’olio e le prese d’aria dei carburatori, che erano chiudibili, correvano lungo i fianchi del muso contendo il riduttore e l’albero per l’elica aerea ed era tanto lungo che al velivolo diedero il nome di “Pinocchio”.
- Elica
- Variatore
- Frizione
- Superficie radiante
- Impianto propulsivo
- Motore Fiat AS.8
- Frizione
- Serbatoio
- Aletta idroplana
- Trasmissione propulsione marina
- Protezione dell’elica
- Elica marina
- Timone marino
- Superficie radiante
Le caratteristiche del “Piaggio PC7” erano:
 Impianto propulsivo: Isotta Fraschini Asso I-500, a 12 cilindri a V, raffreddato ad acqua da 850 Cv di potenza e variamente indicata anche in 800, 820 e 1.050 CV con elica bipala ed elica marina tripala.
Impianto propulsivo: Isotta Fraschini Asso I-500, a 12 cilindri a V, raffreddato ad acqua da 850 Cv di potenza e variamente indicata anche in 800, 820 e 1.050 CV con elica bipala ed elica marina tripala.
Dimensioni:
- apertura alare: 6,75 m c/o gli 8,50 m del “Macchi MC 72”
- lunghezza: 8,85 m
- altezza: 2,45 m
- superficie alare: 9,83 mq
- Pesi a vuoto: 1.403 Kg
- Peso totale: 1.696 Kg c/o i 3038 Kg del “Macchi MC 72”
- Carico alare: 171 Kg/mq
- Rapporto peso – potenza: 2Kg/CV
- Prestazioni: Velocità massima600 Km/h
- Potenza: 800 HP contro i 3000 HP del “Macchi MC 72”
Ambedue i velivoli erano calcolati per una velocità superiore ai 600 Km/h.
Il “Piaggio PC 7” fu un esempio tipico di come la pressione competitiva della “Coppa Schneider” e di tutte le competizioni in genere, spinge i progettisti a migliorare la scienza meccanica, aereodinamica e idrodinamica, proponendo progetti e idee avanzate, che in alcuni casi si dimostrano al di la delle possibilità contemporanee.
Immagini e notizie tecniche tratte da:
Storia di un primato di V. Fradeani
- Edizioni Mursia 1976
- Foto: Arch. F. Harrauer
- Edizioni: Apostolo
- Disegni: F. Harrauer
Altomareblu – Tutti i diritti riservati. Note Legali













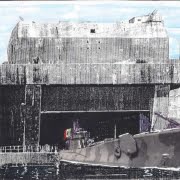
















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!