L’ultimo paradiso
di Antonio Soccol
Oggi vi porto sulla Corrente del Golfo. A Cuba: negli anni Ottanta ci sono andato per venticinque volte (media 2,5 all’anno) ed era un paese straordinario. Non chiedetemi cosa ne penso oggi: non lo so ma, confesso, sono un po’ perplesso. Spero, però, vi piaccia sentire com’era, allora: un quarto di secolo fa.
Veja negra s’immerse ancora una volta. L’acqua era calma, dolce nel tramonto del Caribe. Attorno alla patana tutto era silenzio. Silenzio sul mare a ovest, verso la penisola dello Yucatan. Silenzio sul mare a est, verso Cuba. Silenzio sul mare a nord e a sud, su tutte le tremila isole di mangrovie dell’arcipelago “i giardini della Regina”. Silenzio sul largo canale entro il quale erano ormeggiate la patana e il suo tender, il grosso peschereccio Macabì. La mezza dozzina di piccole imbarcazioni in plastica si allungava verso la corrente del golfo che scorreva convinta, metodica, continua: trattenute tutte da una unica cima alla bitta del patio della patana, le barche beccheggiavano pigre, quasi si raccontassero storie d’amore, di vita e di sole.
Veja negra non si decideva a riemergere : “Coño” disse Antonella, continuando a fissare l’acqua nel punto in cui prevedeva che sarebbe uscita. Il sole ormai era scivolato in mare ma senza sollevare la solita sfacciata apoteosi di technicolor. E senza friggere. C’erano state sere in cui la sua entrata in mare era da film. Ma quella sera il sole era stato più semplice nella sua grandezza, quasi più modesto. Leggera, una piccola brezza incominciò a increspare l’acqua e le barche si allungarono ancor di più sul filo del vento. La grandezza era data dalla pace, dalla calma. Si viveva una grande calma. Non un’attesa di qualcosa di bello o di importante.
Non il ricordo di qualcosa di bello o di grande. Solo il presente: lui sì, bello e grande, dolce e assoluto. Veja negra era ancora sui fondali alla ricerca della sua cena. “Coño” ripetè Antonella e il ghiaccio tintinnò nel bicchiere di ron collins. Era arrivato il momento di prenderne un altro. Questi ron collins andavano giù così in fretta, anche loro erano dolci e calmi. E davano questa grande pace. “Vieni – dissi – andiamo a prendere un altro di questi ron collins. Quella veja negra deve aver raggiunto l’abisso degli abissi a quest’ora e non tornerà mai più a galla. Scommetto che qualche barracuda se la sta mangiando con tutte le sue piume nere e poi magari se ne metterà una in testa e andrà in giro a fare l’indiano”.
La patana era lunga una trentina di metri e larga una decina. Da un lato una sorta di patio dove godere la brezza, poi un gran salone per la tv e relativi giochini. Al centro uno spazio aperto raccoglieva le attrezzature sportive: il grosso compressore per caricare le bombole, i motori fuoribordo per le barchette, gli sci nautici e tutti gli equipaggiamenti da sub: mono da 15 litri, mute, pinne, maschere, cinture di zavorra. Dall’altra parte un gran salone ospitava il banco bar e i tavoli del ristorante. In fondo la cucina: una grande cucina con freezer degni di un grande albergo. Al piano superiore le camere da letto. Tutte con aria condizionata con bagno e doccia e ciascuna con un davanzale a slancio sul mare.
Veja negra uscì di colpo dall’acqua con un gran battito di ali. Uscì di poppa e aveva il collo tutto teso in avanti, il grasso corpo lasciava cadere gocce che formavano lenti cerchi sulla superficie del mare. Volò bassa a lungo, quasi non riuscisse a prender quota, affaticata forse dalla lunga apnea o appesantita dal grosso boccone che tentava disperatamente di inghiottire. “Coño”, concluse Antonella. E Jorge ammise “Sì, questi cormorani tropicali hanno una apnea imbattibile”.
Jorge aveva passato quasi un anno in quella zona. Accampato con una tenda su una spiaggia, aveva studiato l’ambiente, il gioco delle correnti, i luoghi di immersione. Tutto per poter ancorare la patana nel posto migliore. Poi la grande zattera era arrivata e da allora era stato proibito di chiamarla patana: si doveva chiamarla “Hotel the last paradise”. Ed era una regola che con tutti i turisti veniva rigorosamente rispettata: “albergo l’ultimo paradiso”.
Veja negra ormai era sparita. Con un balzo s’era sollevata sopra la cortina di mangrovie che circondavano il primo isolotto. Quello dove c’era una specie di deposito di carburante: una casupola costruita tutta con grosse conchiglie. “Ci sono più uccelli marini qui, in questo arcipelago, che in tutta Cuba” disse Jorge mentre Gordo, il barman, entrava nel patio con un paio di ron collins “Esto par Antonio: sin azucar” disse allungandomi un bicchiere con una leggera smorfia. Gli risultava incomprensibile che non mi piacesse lo zucchero: a Cuba è quasi un’offesa prendere le cose amare. E Gordo era cubano fino al midollo. Che gli piacesse lo zucchero lo dimostravano i suoi 100 e rotti chili di peso e il soprannome. Però sapeva preparare dei ron collins magnifici: “Quiere otro?” chiese con il suo sorriso aperto. Non lo scandalizzava di certo il gran numero di ron collins che ci preparava. Era stato lui, sin dal primo giorno, a dirmi “Comprati un po’ di bottiglie intere e poi te le amministro io; bevi di più e ti costa meno”. “Ocappa, amigo – gli dissi – Ahi, sì: quiero otro”.
“Caribe del Sur” era un puntino lontano sul mare. Navigava lenta all’esterno dell’arcipelago, seguendo il canto. Stavamo preparandoci per un’immersione quando il puntino divenne barca. Era una barca in legno, poco più di 6 metri: un tendalino in stoffa grezza copriva l’uomo dal massacro del sole. Il borbottio del piccolo diesel avanzava caracollando sulle brevi onde della risacca. “E’ Alfaki” disse Jorge. E lo disse con quel tono che uno userebbe per dire una grande assoluta logica verità. E aggiunse “ E’ un pescatore di Santa Cruz del Sur”. Seguimmo la barca con gli occhi mentre ci incrociava e poi, finchè sparì all’orizzonte. “Questo è un uomo che tu devi conoscere” disse Jorge, guardandomi fisso negli occhi. “E’ un uomo incredibile. Vive in barca sei mesi pescando per la cooperativa. Poi torna al suo paese, vi rimane per un paio di settimane, si sbronza completo e quindi riprende il mare per altri sei mesi. E fa così da circa cinquanta anni”. “Sì certo: voglio conoscerlo” gli dissi.
Dopo l’immersione, Jorge disse “Andiamo da Alfaki” e portò il fuoribordo fuori dal canto e poi verso ovest. Navigammo per una ventina di minuti, sette o otto miglia di mare, costeggiando sempre le isole di mangrovie dell’arcipelago. Poi entrammo in un canale basso dov’era ancorato un peschereccio: a poppa si leggeva ponton. “E’ un centro di raccolta del pescato” spiegò Jorge. “Queste zone sono lontane dalla terraferma: il porto più vicino è a 60 miglia. Così i pescatori portano qui tutti i giorni quello che pescano: lo consegnano a questa barca “ponton” dove il pesce viene messo sotto ghiaccio e poi indirizzato a terra con una barca veloce”.
Attraccammo con precauzione per non danneggiare le nasse di raccolta delle aragoste: un impressionante numero di antenne si sollevò dal pelo dell’acqua e tutte facevano cenni frenetici, sapete come sono le aragoste quando si agitano, sono proprio curiose. Salimmo sul ponton. C’erano bambini dappertutto e materassi in coperta. “Le scuole sono chiuse e i pescatori si portano i ragazzi a vivere un po’ qui. Altrimenti non li vivrebbero mai” spiegò Jorge.
Ogni tanto arrivava una barca, qualche ferrocemento con quattro/cinque uomini di equipaggio: passavano al ponton le cassette del loro pescato che venivano subito pesate e riempite di ghiaccio. Metà stiva del ponton era piena di stecche di ghiaccio. I ragazzi si divertivano a sminuzzarlo con colpi di martello e a seminarlo nelle cassette del pesce. Mentre gli equipaggi riassettavano i loro ferrocementos, i cuochi di bordo preparavano da mangiare. Come in tutti i mari del mondo, nelle pentole c’erano più galline che pesci. Ma molti uomini mangiavano filetti di pesce essiccati al sole: mosciame tropicale. Dopo mezz’ora c’erano parecchie barche ormeggiate attorno al ponton e c’era dell’allegria. Si sentivano scoppi di risate, chiacchiere ad alta voce, qualcuno cantava. Le antenne delle migliaia di aragoste si muovevano sempre più frenetiche.
Alfaki arrivò di sottovento che quasi non me ne accorgevo. Era in piedi a prua e aspettava che “Caribe del Sur”, la sua barca, perdesse l’abbrivio. Pantaloni di tela blu, camicia blu, piedi scalzi, le lunghe braccia magre e asciutte, dolcemente abbassate: le mani forti ma sottili tenevano la cima d’ormeggio pronta. Il viso era quello di un uomo che da cinquant’anni vive in mare. Una infinità di rughe e di solchi parlavano della vita di ogni onda, di ogni raggio di sole, di ogni refolo di vento, di ogni lancio di lenza. Di ogni guizzo di pesce. “Buenas tarde” disse dolcemente, allungandomi la cima. “Buenas tarde” gli dissi, mentre davo di volta ad una bitta. “Oje, Alfaki” dissero i ragazzi. “Oje, amigo” disse Jorge.
Passò da “Caribe” al ponton, scavalcando il tentibene con un movimento semplice e sicuro che non conteneva arroganza né presunzione. Si muoveva con una linearità e con una serenità assolute. Scaricò due cassette di pesci: barracuda, carangidi, qualche cernia. Fece firmare il suo libricino dopo la pesata. Riprese le cassette vuote. Le passò a bordo. Con un movimento del polso sciolse la cima e allargò di prua. “Caribe” si diresse al largo. “Dove va?” chiesi a Jorge. “Lui è così. Non gli piace la gente, la confusione. Adesso si porta in qualche ridosso e si cucina la cena e poi dorme. Domattina alle quattro è già al largo”. “Vorrei andare al largo con lui, vorrei pescare con lui, vorrei vederlo calar le lenze e imbarcare i pesci. Vorrei bere del ron con lui” dissi. Al ponton ci regalarono dei pesci e dei filetti essiccati al sole che mangiammo mentre navigavamo verso la patana.
Alfaki venne alla patana due giorni dopo. Miguel, il cuoco, uno dei cuochi più fantastici che ci siano in giro per il mondo, me lo disse ponendomi davanti un piattino di pesciolini fritti. Era una sua splendida abitudine. Si metteva alle spalle di Fello quando pescava, gli prendeva i pesciolini più saporiti, si chiudeva in cucina a spadellare e appariva in un attimo dopo con il suo piattino. A qualsiasi ora del giorno. Me lo aveva proposto alle tre di notte dopo che ci eravamo scollati ron in quantità industriale e anche alle undici di mattina quando, dopo l’immersione, uno si sente un lupo affamato. Oppure alle sette di sera come stuzzichino. E Gordo, il barman, ne approfittava per preparare ron collins. Così venne Miguel e mi disse “Alfaki està aqui”.
Mi infilai un paio di pacchetti di sigarette nelle tasche dei jeans e presi le macchine fotografiche.
E andammo.
Alfakì allargò a poppa spingendo dolcemente con il palmo della mano sulla fiancata della patana. La sua barca, Caribe del Sur, dondolò un attimo, come indecisa e poi puntò verso il centro del canale. Alfakì si passò la barra del timone fra le gambe, abbassò lentamente una mano e diede un po’ di gas. Il piccolo diesel di Caribe del Sur borbottò senza fretta e lo scafo incominciò a danzare sulle brevi onde. Era mattina. Una mattina di sole sull’arcipelago “Los Jardines de la Rejna” a sudovest di Jucaro, paesino di pescatori della provincia di Ciego de Avila, al centro della costa sud-occidentale di Cuba. Davanti: il Golfo del Messico; in alto verso destra: la penisola dello Yucatan; sessanta miglia alle spalle: l’isola di Cuba.
Tutt’attorno isole disabitate: mangrovie, spiagge, piccoli reef, qualche palma. Unici abitanti fissi: una coppia che vive all’isolotto di Algodon (significa “cotone”) che si tengono compagnia con le stranezze di un buffo maiale domestico, tutto nero. In questo dedalo infinito di cayos ci sono i pescatori. Pescatori come Alfaki, gente che vive per sei mesi consecutivi in mare aperto, nella Corrente, senza mai rientrare a terra, ai porti d’origine. Gente bianca e gente di colore. Gente giovane e vecchia. Gente seria e gente allegra. Ma tutta gente con le caratteristiche della gente di mare: gesti lenti, pacati, sereni, sicuri; pelli rotte dal sale e dal riverbero; mani tagliate dalle cime e dalle lenze e dalle squame dei barracuda e delle cernie; piedi scalzi capaci di camminare sull’arena bollente del Tropico; figure eleganti come nessun maquillage e nessun sarto potrebbe immaginare, con quelle facce da attori rubati a Hollywood e con quelle camice cachi e quei pantaloni stazzonati degni di una copertina della più autorevole rivista di moda.
Caribe del Sur trotterellava al centro del canale di mangrovie. Lunga circa sei metri e costruita tutta in legno massello, la barca entrava con disinvolta dolcezza nelle onde, le scavalcava aprendo appena l’acqua ai lati. La leggera brezza spruzzava ogni tanto a bordo, ma erano piccoli sbuffi d’acqua che non disturbavano. Alfaki si occupava poco della rotta. Sembrava quasi che la barca sapesse da sola dove andare: là fuori, dove c’è il canto, la caduta del reef. Dove la profondità passa di colpo da pochi metri all’abisso del blu. Dove giocano i barracuda e le cernie, ma dove passano anche grandi carangidi e i carey (tartarughe) e anche los tiburones, gli squali. Alfaki non voleva pescare pesci tanto grandi. Non cercava la grande preda. In vita sua aveva già pescato tutto: squali e tartarughe, marlin e guazas (cernie giganti da oltre 200 chili). Alfaki cercava qualche barracuda, qualche urel: dieci, dodici pesci da qualche chilo l’uno sarebbero stati sufficienti perché quello fosse un buon giorno di pesca. Alfaki aveva, sotto al ponte di Caribe del Sur, una buona bottiglia di ron Caney e un paio di pacchetti di sigarette Populares nei taschini della sua camicia cachi. Questo gli bastava.
Era stata una buona stagione. Una barca aveva pescato tantissimo pesce e così gliene aveva regalato un po’ e lui aveva raggiunto la sua quota facilmente. Ogni pescatore della zona appartiene ad una cooperativa di pesca e si assume una certa quota di pesce da portare al centro. Se non ci riesce, in realtà non succede niente di importante, ma ogni pescatore ci tiene a raggiungere la sua quota e a mantenere il suo impegno con la cooperativa. E Alfaki aveva raggiunto da tempo la sua quota. Così avrebbe potuto ritornare a Santa Cruz del Sur, al suo “porto di armamento”, già da qualche giorno. Ma cosa avrebbe fatto a Santa Cruz del Sur? Si annoiava tremendamente a terra, ogni volta che ci andava. E poi finiva che si ubriacava per far fuori la noia di essere a terra invece che in mezzo al mare, al Golfo del Messico. Una volta c’erano le ragazze. Una volta. Oggi, a settanta anni, le ragazze lo interessavano meno. Veramente le donne non lo avevano mai interessato tanto: impicci. Mica puoi portar per mare, sei mesi per volta, una donna, e poi, come gran regalo, farle vivere quindici giorni a terra, passando naturalmente da una sbornia all’altra.
Le donne: carne da tiburones, si dice tra i pescatori cubani quando nasce una femmina, carne buona per i pescicane. Bè, non sempre s’intende. Una famiglia, comunque, Alfaki non l’aveva mai voluta e così, da cinquantadue anni, viveva tranquillo sul mare, facendo il pescatore. I primi ventidue anni aveva avuto solo una barca a remi e pescava solo. Da trent’anni s’era aggiornato con la nuova barca a motore, Caribe del Sur, uno scafo che sembrava nuovo a guardarlo anche da vicino. Tenuto con amore, ben calafatato, con un piccolo ponte di coperta lindo e sotto: tutto in ordine, perfetto. Perché, adesso che si sentiva viejo, Alfaki ogni tanto pescava con un amico, più o meno della sua stessa età. E così, su una piccola barca come Caribe del Sur è un guaio a starci in due se a bordo tutto non è perfettamente in ordine. E poi è facile tenere in ordine tutto, quando non c’è molto. Il motore, la bottiglia di ron, le sigarette, la scatola di fiammiferi, il braciere, due bicchieri di latta, due piatti di ferro, un po’ di carbonella, una manciata di sale, una mezza bottiglia di olio, un vaso per sgottare, due cassette di legno per metterci il pesce. Gli ami di scorta sono appesi sui sostegni del tendalino che difende dal sole e sono comodi, a portata di mano, assieme ad alcune fettuccine di tela che sembrano dei segnavento e servono, invece, per proteggere le dita dal lavoro delle lenze di filo d’acciaio.
A bordo non c’erano bussole. Di giorno, a Alfaki, bastava il sole. Di notte, le stelle, ma in senso generale e senza riferimenti particolari. Nessuno gli aveva mai insegnato che il sole sorge a est e tromonta a ovest né, men che meno, dove fosse la Polare, il Piccolo Carro o quello Grande. Tutta roba inutile. Per lui. Che poi, un po’più a sud, la Polare non ci fosse nemmeno più e ne prendesse il posto una stella che si chiamava Croce del Sud gli era semplicemente impensabile. A Alfaki bastava guardare il colore dell’acqua per sapere dov’era e dove doveva andare. Gli bastava annusare il vento per capire se era in arrivo un fronte frio o un ciclone: era metereologo senza nemmeno conoscere questa parola e navigatore perfetto senza avere la più pallida idea di cosa fossero i punti cardinali. Per lui, Flavio Gioia, inventando la bussola (almeno stando ai “si dice” e cinesi permettendo), aveva fatto una scoperta del tutto superflua.
Quando le mangrovie allargarono il canale, Caribe del Sur virò a sinistra, verso la Corrente. E prese il mare al mascone. Alfaki guardò il sole: era già abbastanza alto. Poi guardò il mare. E mosse le labbra. Ma non pronunciò alcun suono. Alzò la mano e prese una fettuccina di tela, la osservò con attenzione e se ne mise un angolo in bocca. Strappò per lungo la fettuccina e così ne ottenne due. Poi tolse dall’ordito della tessitura due fili e li poggiò sul tricarino al suo fianco. Con calma arrotolò la prima banda di tela sull’indice della mano destra, avvolse un capo di uno dei due fili dell’ordito sull’alluce del piede destro e incominciò a stringere l’altra banda del filo attorno alla tela, facendo ogni tanto forza per serrar bene: allungava il busto indietro e la gamba in avanti. Così la protezione del dito risultava ben modellata e stretta. Con un taglio netto, troncò il filo e mise da parte l’avanzo.
Tornò a guardare il mare, il colore delle onde. Mosse ancora una volta le labbra e ancora una volta non pronunciò alcun suono. Poi ripeté l’operazione sulla mano sinistra. Ogni movimento dimostrava lunga abitudine alla vita in solitario, all’essere solo, unicamente in grado di darsi una mano con le proprie capacità. La consuetudine all’autonomia. Adesso che le dita risultavano protette dalle bende e che le mani erano, quindi, pronte al lavoro della pesca, Alfaki preparò le esche. Prese da una cassetta di legno un pesce, un piccolo pesce corallino pescato il giorno prima. Lo guardò bene. Prima da un lato e poi dall’altro. Sì, decise che sì, che poteva andare bene. Tagliò il pesce in filetti e ne arrotolò con cura la carne attorno alla curva dell’amo. Operava con amore per la perfezione e ogni tanto muoveva le labbra: sempre senza lasciar uscire alcun suono. Poi, con il filo, bloccò bene l’esca.
Caribe del Sur era ormai lontana dalle isole che stavano già scadendo alla vista di poppa. Il colore del mare era cambiato. Adesso era blu profondo. Quel blu che, con la sua intensità, indica la grande profondità. Mi trovo sempre in gran difficoltà quando devo descrivere il blu del Caribe di Cuba. Un giorno ho scritto: “Questo blu è intenso come un cielo di Van Gogh, aggressivo come il più formidabile Picasso e sensuale come il più concentrato Egon Schiele. Ma, poi, nessuno è riuscito a trovare nei cataloghi della Duco o di altre ditte di inchiostri, di colori, di smalti, di vernici un blu come questo Blu. E allora io ho proposto di inventarlo e di chiamarlo Blu Caribe”.
Con due rapidi movimenti dei polsi, Alfaki fissò il terminale dell’esca alla lenza di cavetto d’acciaio. Si guardò attorno. Diminuì i giri del motore. E si accese una sigaretta. Tutto sembrava un rito, ma non vi era la minima traccia di ritualità nei suoi gesti. Neanche nei movimenti della barca. E nemmeno nei suoi pensieri. Tutto era semplicemente ineluttabile e aveva la cadenza della consuetudine: l’essenzialità di ogni azione veniva dall’esperienza.
Alfaki non sapeva nuotare. In cinquantadue anni di vita sul mare non aveva mai sentito il bisogno di tuffarsi nell’acqua, di fendere con il proprio corpo quello immenso dell’Oceano, dove domina assoluta e incontrastata Yemanjà, la sirena, la Madre Acqua, la Signora del mare. Nessuno lo ammette, ma tutti i pescatori del Caribe e giù sin oltre le coste del Brasile, pensa a Yemanjà, colei che “domina questi mari, che adora venir a vedere la luna nelle notti senza nuvole, che ama la musica dei negri…”, come giustamente scrive Jorge Amado in “Mare morto”, Yemanjà, il mare, l’oceano stesso.
“Qual è la tua avventura di pescatore più pericolosa” chiesi, dandomi subito dello stupido per l’imbecillità della domanda. Ma Alfaki non mi considerò stupido. Disse “Io no so nuotare. Un giorno c’era una tartaruga in una rete e io ho cercato di prenderla. Ma sono caduto in acqua. La tartaruga si era liberata dalla rete ma io non volevo mollarla. E lei mi portava sotto. Io cercavo di venire a galla ma lei mi portava giù. E io non volevo mollare. Ma avevo paura. Ho avuto paura perché non so nuotare. E perché era una tartaruga grande. Molto grande. E questa è stata la cosa più pericolosa della mia vita. Anche le donne sono pericolose. Ma in mare non ce ne sono” disse. “Hai sempre pescato pesci di barriera, di canto?” chiesi. “Ho pescato tutti i pesci che ci sono in questo mare. Pescare è il mio mestiere” disse. “Anche pesci grossi?” chiesi. “Sì. Anche pesci grossi” disse. “Anche pescicane?” “Sì, anche pescicane”disse. “E come sono?” chiesi. “Grossi” disse. Tirò fuori la bottiglia di ron e accese da fumare. “Mi chiamo Alcidez Caso. Ma da sempre sono Alfaki, per tutti. Per me va bene” disse.
Caribe del Sur si trovava proprio sopra al canto. Nulla lo indicava ma Alfaki sapeva d’essere sul punto giusto, lungo quella linea subacquea che divide la vita stanziale del reef e del corallo da quella fluida e magica della Corrente, il confine fra il domestico e l’infinito. La sigaretta, fumar daña su salud, c’era scritto sul pacchetto di “Popular”, era finita. Fakì la spense fra le dita e non buttò il mozzicone in acqua. Lo poggiò sul trincarino. Poi prese la lenza con la sinistra e l’esca con la destra. Protese delicatamente il braccio fuoribordo, ruotò il polso verso poppa e lanciò, lasciando poi scorrere veloce la lenza fra le dita.
La Corrente portava la barca, la lenza, l’esca e Alfaki. E c’era una grande armonia. Mare, scafo, attrezzi, uomo: tutto era in sintonia: tutti erano complementari e l’uno era gli altri e con gli altri. Sembrava davvero non ci fosse soluzione di continuità in tutto l’insieme. E tutto era immerso nell’indescrivibile Blu Caribe.
Alfaki sentì lo strappo. Qualcuno aveva abboccato. Un morso deciso ma non violento. Secco ma non isterico. Non era di certo una picua, un barracuda. Forse poteva essere una urel. Forse un pesce corallino, di quei curiosoni che, anche fuori dal loro habitat tipico, non sanno mai resistere alla tentazione di un buon piattino di carneada fresca. Alfaki recuperò rapido la lenza. Recuperava a grandi bracciate, lasciando cadere il cavetto d’acciaio dentro a Caribe del Sur. E intanto muoveva le labbra. Parlava senza emettere suoni. Parlava da solo e con il pesce. A poppa, il pesce venne a galla e sembrava inseguire la barca. Fakì lo imbarcò senza fatica. Era un pesce corallino. Ma gli mancava un pezzo di corpo. Guizzava ancora. Ma un barracuda se ne era mangiato quasi la metà mentre Alfaki gli diede un colpo di remo in testa e lo buttò in una cassetta di legno. Pulì l’amo e lo preparò con un’altra esca. Pulì con un po’ d’acqua il mare dove il pesce aveva macchiato venendo a bordo. Poi accese un’altra sigaretta. Guardò il sole. E lanciò di nuovo nella Corrente.
La barca navigò quasi tutto il giorno sul canto. Il sole andò su in alto. Tutto era luce e Blu. Solo i piccoli baffi di Caribe del Sur disegnavano, sulla Corrente del Golfo, qualcosa di bianco. Faceva caldo. Ma in mare si stava bene. Improvvisamente passò un aereo e macchiò di bianco anche il cielo. Era altissimo e lucente, come un proiettile. Allora Alfaki allungò la mano sotto al ponte di Caribe del Sur e prese la bottiglia di ron Caney. La stappò con i denti per non mollare la lenza. Si tolse il turacciolo di bocca. Lo poggiò delicatamente sul ponte. Guardò l’aereo alto nel cielo. E bevve a canna: “Esto es el avion mio”, disse sottovoce come se temesse di disturbare qualcuno. Poi rimise il tappo alla bottiglia e ripose il ron sotto il ponte. Il sole raggiunse il suo massimo poi incominciò a scendere, mangiando le ore. Solo più tardi una picua, un barracuda, abboccò. Non lottò molto. I barracuda sono aggressivi solo in apparenza. Quando mordono un’esca non combattono affatto e confessano subito tutta la loro codardia. Quando venne a bordo, Alfaki lo randellò sulla testa e lo mise nella stessa cassetta di legno dove aveva messo il pesce corallino. Poi girò la barca.
Caribe del Sur prese la via del ritorno. Non era stata una buona giornata di pesca. No. Non lo era proprio stata. Ma, forse, sarebbe stata migliore domani. I pesci son fatti così. Qualche volta non mangiano e allora il pescatore si sente salao. Ma la fortuna, pensava Alfaki entrando nel canale delle isole di mangrovie, esiste solo se ci credi. L’importante, pensava, era vivere per mare. Questo sì era importante. Anche perchè, onestamente, non esistevano alternative. Tutto il resto non sarebbe stato “vita”.
Quando Alfaki fu vicino al ponton vennero tre uccelli: un cormorano negro, un gabbiano bianco e un pellicano grigio. Volavano sopra Caribe del Sur, a poppa. La vieja negra sbatteva affannosamente le ali come se qualcuno la inseguisse, la gaviota blanca aveva il volo più disteso e regolare, el pelican era possente nei suoi lenti colpi d’ala.
Alfaki passò ai ragazzi del ponton una cima. Nelle nasse appese all’esterno della barca-pontile, mille e mille antenne di aragoste si agitarono di nuovo e sempre freneticamente, come per salutarlo. Ma lui le ignorò. Senza dire nulla passò ai ragazzi del ponton anche il barracuda. L’unico pesce che avesse pescato. Poi guardò gli uccelli che si erano fermati nel loro volo a pochi metri. Prese dalla cassetta di legno il pezzo di pesce corallino. E lo buttò in mare. La gaviota blanca si tuffò. Ma il pellicano, in picchiata, arrivò per primo sulla preda. E sprofondò sott’acqua con la bocca spalancata. Vieja negra, il cormorano se ne andò con il suo volo affannoso. Sembrava un po’ triste, ma volava verso il sole che incominciava a tingere di rosso l’acqua del Caribe. Se ne andò verso il largo, dove passava la Corrente.
Jorge mi mise in mano un manubrio. Di quelli che si usano per far ginnastica ai muscoli delle braccia. Tre o quattro chili di peso. Legò al centro una lunga sagola e disse “Mettiamolo in barca”. Poi caricammo come sempre le bombole e le sacche con tutta l’attrezzatura sub. “Oggi andiamo in un posto nuovo. Dove non c’è il petagno” disse Jorge. Così capii che il manubrio sarebbe servito da ancora e che la sua era una scelta bella perché un’àncora rompe con le marre il corallo mentre un manubrio no. Navigammo meno di dieci minuti nel solito mare tutto nostro, tutto vuoto, tutto limpido. E Jorge disse “E’ qui”.
L’immersione nel Caribe, in agosto, è semplice. La muta è ridicola. Profondimetri e decompressimetri non servono. Quanto al gav è questione di abitudine. Se non scendi lungo il canto, la profondità media d’immersione è 18 metri e l’acqua ha 26/28 gradi di temperatura. Per questo puoi stare in acqua quanto vuoi. E in pochi minuti sei pronto.
Si tuffò per primo Jorge che andò a posare dolcemente il “manubrio-ancora” sul fondo. Quindi fu la volta di Antonella. Io scesi per ultimo. Nei primi metri tutto era semplicemente bello come sempre. Allegri pesci di barriera festeggiavano il nostro scendere. E in basso il fondale era la solita pazzesca esibizione di coralli, di gorgonie, di spugne coloratissime. Fu un urlo di Antonella a indicarmeli. Un gruppo di una cinquantina di carangidi che pascolavano come tanti vitelli, poco lontani sulla destra. Jorge stava risalendo per venirci incontro. Ci lasciammo cadere in mezzo alla mandria. E fummo addottati. Tutti e tre. Avevamo carangidi a destra, a sinistra, sopra e sotto. “Ureles” disse Jorge togliendosi l’erogatore di bocca. Riusciva a parlare benissimo sott’acqua emettendo suoni precisi e parole comprensibili. “Ureles” ripetè e indicava i pesci che ci venivano addosso da tutte le parti, ci annusavano quasi e poi ci seguivano. Capii che doveva essere il nome in gergo di questi carangidi: vitelli argentei, leggermente venati di grigio. Pensavo che si sarebbero dati a fuga precipitosa: decisero invece di fare l’immersione con noi. Si accodarono. Ogni tanto qualcuno veniva davanti, ci guardava con curiosità e poi tornava in gruppo. Talvolta sparivano di colpo scartando dietro una roccia, e riapparivano davanti. Tutti assieme. E ci venivano incontro, quasi addosso. A meno di un metro di distanza la mandria si apriva in due e ci avvolgeva. E infine tutti insieme dietro: il muso dei primi sulle nostre pinne, costringendoci a nuotare guardando indietro.
Incontri, in mare, è facile farne. Ma sono quasi sempre fugaci. Attimi che devi cogliere e vivere in fretta. Momenti di splendida intensità che hanno sempre il sapore dell’imprevisto e dell’improvviso. Questo sentirci pesci fra i pesci, carangidi fra i carangidi, ureles fra le ureles durò tutta l’immersione: 58 minuti esatti di orologio.
Durò anche quando incontrammo la guasa, la cernia gigante. Stava sotto una spaccatura e mostrava il muso incorniciato in una selva di corallo nero che pendeva morbido dall’alto. “Guasa”, urlò Jorge. Ma l’avevo già vista. Era ferma, immobile. Bellissima e sicura di sé. Mi avvicinai guardandola negli occhi e molto lento. Ma mi veniva da ridere a pensare che dietro le mie pinne c’era quella mandria di carangidi che sembravano vitelli. Mi lasciò giungere a due metri. Poi l’acqua si spostò. Ci fu anche uno schiocco forte e secco. E d’istinto mi portai le mani alle orecchie. Ma il colpo fu uno solo. E la guasa non era più dov’era prima. Mi passò davanti ed era un sommergibile, una balena, un missile, non so. Grandissima e splendida. Potente e superba. Un amore. Non andò lontano. Appena una ventina di metri più in là. Si girò lentamente su se stessa e si mise a guardarci. Jorge e Antonella salirono di qualche metro per vederla dall’alto in basso. Metà mandria di ureles li seguì. Io ripresi ad avvicinarla. Con l’altra metà della mandria alle spalle. “Non muoverti, non muoverti” pensavo forte “Non muoverti guasa: non voglio farti del male. Non ho nulla da darti da mangiare. Non ho nulla in mano. Non voglio far altro che accarezzarti. Che toccarti e dirmi poi che sei vera, che non ti ho sognato. Stai ferma, ti prego. Voglio solo darti una carezza. Voglio sfiorare la tua pelle e passarti la mano sul muso. E, se me lo lasci fare, grattarti un momento sulla testa. Come con i gatti e con i leoncini. Non muoverti, non muoverti ti prego”.
Allungai la mano sin da lontano in modo che si abituasse alla mia posizione e pinneggiai lento, parlandole sommessamente. Sapevo il rischio. Quella faccia splendida ospitava una bocca tremenda per forza e dimensioni. Una mano poteva tranciarmela senza grande sforzo: il suo corpo era almeno il doppio del mio. I caringidi in proporzione sembravano pesciolini. Ed era ferma, immobile. Mi lasciò avvicinare che mancava niente a toccarla. Poi fece di no con la testa, con la sua immensa testa. Si girò lenta. E se ne andò. Dolcemente, ondeggiando un po’ sui fianchi. E senza nemmeno più degnarmi di una occhiata. Sparì presto nel blu. E io le dissi “Sei una gran bastarda”. “Esta guasa està sempre aqui. Es una amiga”. Disse poi in barca Jorge che voleva imparare l’italiano. Ma io quel giorno non avevo molta voglia di parlare perché pensavo a quella grandissima bastarda che mi aveva detto no con la testa e che era grande il doppio di me.
Fello in spagnolo vuol dire “brutto”. Fello è il soprannome di un pescatore di Ciego de Avilla. Mi aveva portato nei laghi interni a pescare truchas, trote giganti. E poi era venuto con noi alla patana. Fello pescava sempre. Di giorno e di notte. All’alba e al tramonto. Sui laghi e al mare. Dalla patana e dalla barca. Dalla spiaggia. Ovunque e sempre. Aveva tre o quattro canne da pesca con mulinello. Fumava e lanciava la canna. Lanciava e fumava. “Esto es un sabalo. Esto es un picua. Esto es un carey” diceva e rideva. “Tu sei un carey” gli dicevo. Perché mi scherzava spesso. Voleva farmi credere che pescava all’amo le tartarughe. “Y tu es un tiburon” mi diceva, lanciando di nuovo. “ Tu es un pescador de sargassi” gli dicevo anche. Ma Fello pescava molto. Pescava un pesce e lo ributtava in mare perché era piccolo. Ne pescava un altro e buttava anche quello perché era brutto. Ne prendeva un terzo e diceva che era troppo grande. Un giorno, sul lago, lo vidi prendere almeno una trentina di trote ma solo due rimasero a pagliolo. “Mi piace lanciare. Mi piace trovare l’esca giusta, la lenza giusta, la canna giusta. Mi piace tirare a bordo, a terra, il pesce.
Poi non mi interessa più. E lo ributto in acqua. E’ più giusto così. Perché così i pesci non finiranno mai e potrò pescare sempre” diceva. Un giorno lottò quasi mezz’ora con un barracuda grande. Era seduto sul bordo della patana e lottava con il pesce. E fumava. Intorno tutti a guardare, a commentare. I ragazzi a ridere. Gordo portava da bere ed era bello vedere la canna piegarsi sul tiro del barracuda e Fello che dava lenza e poi lento la recuperava e il pesce che un po’ alla volta si lasciava portare sottobordo. Finchè venne a galla e Fello lo salpò con un grosso guadino. Miguel, il cuoco, disse “Dammi quel pesce che ne faccio filetti”. E Fello disse. “No. Questo pesce è stato molto bravo. Ha lottato bene. E merita di tornare in mare”. Gli accarezzò un momento il corpo lungo, argenteo e affusolato e lo lanciò al largo. Il barracuda volò, la sua pelle brillò nel sole. Ed era bellissimo. Cadde bene in mare. Rimase un attimo immobile come per orientarsi. Poi guizzò rapido nel blu.
Macabì, il grosso peschereccio, impiegò quasi sei ore per riportarci al porto di Jucaro. Navigò a poco meno di dieci nodi attraverso tutte le isole di mangrovie dell’arcipelago. Gli uccelli marini volavano a poppa. Io salii sul ponte in alto, con una bottiglia di ron. Guardavo la patana scomparire in lontananza. Guardavo il mare blu. Guardavo le mille e mille isole. E sotto le mangrovie vedevo le timide iguana scappare, i timidissimi rutilas nascondersi fra gli arbusti. Guardavo i santoya (“Usted no sabe que es un santoya? Un santoya es un cangrejo grande, un granchio molto grande”, aveva detto Jorge) scavare le loro inutili lunghe gallerie nella sabbia. Guardavo le spiagge deserte che nessuno aveva mai calpestato. Guardavo le “gatas” gli squali nutrice, dormire nelle ombre delle madrepore. Guardavo i barracuda sfuggire l’amo innestato di Fello. Guardavo la guasa, immensa, che mi aveva detto di no con la testa, con la sua grossa testa.
Guardavo la mandria di ureles pascolare fra le gorgonie. Guardavo Alfaki lottare con la tartaruga e poi lo guardavo mentre beveva ron: “Sembra una copertina di Vogue”, aveva detto Antonella. E alludeva alla eleganza stupenda della sua dignità di uomo: di uomo di mare che non sapeva nuotare. Guardavo tutte le veje negre del mondo immergersi in cerca di cibo nel blu e poi uscire dall’acqua sculettando e lasciando cadere gocce nel tramonto. Guardavo il sole immergersi friggendo dentro il mare. Guardavo l’apoteosi delle nuvole infuocate dal riflesso. Guardavo la mia bottiglia di ron. Guardavo e bevevo. Sapevo che non sarei più tornato in quell’ultimo paradiso.
Articolo apparso sulla rivista “Barche” in due puntate nei fascicoli di settembre e ottobre 2007 nella rubrica “Navigando” e riprodotto per g.c. dell’autore. – Tutti i diritti riservati. Note Legali



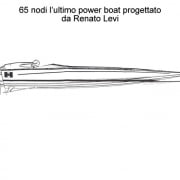



















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!